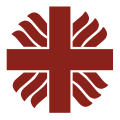Sembra, appunto, paradossale ma la parola volontariato trova la propria origine storica nel servizio militare prestato oltre il periodo di leva obbligatoria. Lo sembra perché nell’accezione comunemente diffusa oggigiorno ha invece assunto un significato diverso, quando non addirittura opposto.
Sembra, appunto, paradossale ma la parola volontariato trova la propria origine storica nel servizio militare prestato oltre il periodo di leva obbligatoria. Lo sembra perché nell’accezione comunemente diffusa oggigiorno ha invece assunto un significato diverso, quando non addirittura opposto.
Il volontariato è ciò che facciamo perché lo vogliamo, è appunto un movimento della volontà. Perciò non determinato da altri fattori, quali la necessità di provvedere ai nostri bisogni materiali – forse da quelli materiali – , ma dal desiderio di donare parte di qualcosa di sé, solitamente il tempo, a quelle situazioni in cui, per infinite ragioni, ci sono delle carenze. In questo senso, il volontariato è difficile da incasellare in una definizione stringente ed univoca. Sembra quasi far parte di quei concetti talmente usuali e consueti che se ci viene chiesto di definirli non ne siamo capaci, pur sapendo sufficientemente di che cosa si tratti.
È un modello di azione, individuale e sociale, orientato allo svolgimento di “attività gratuite a beneficio di altri o della comunità”. Come tale, si connota per un’utilità intrinseca ed una estrinseca: la prima ricade sul volontario medesimo, che dalle diverse azioni che sceglie di mettere in atto senza rintracciarvi un immediato e diretto tornaconto personale, comunque può trarne soddisfazioni personali non indifferenti, sentendosi utile, risolvendo problemi, “restituendo” alla società, nelle sue personificazioni più fragili e ferite, un po’ di quello che sente di aver ricevuto. Il volontariato appare perciò utile alla società e allo Stato, perché supplisce a tante carenze, più o meno evidenti. Questa tendenza, ormai entrata nel sentire comune purtroppo, ha tra le altre conseguenze quella di “normalizzare” la volontà, quasi di darla per scontata, o peggio, di tradurla in obbligo. Perché i bisogni cui fornisce risposta e a cui supplisce sono tanto gravi e reali che non possono restare senza risposte. Altro rischio è quello di una normalizzazione interna, che priva il volontariato della sua anima perché lo trasforma in una pratica assistenzialistica anziché nella promozione delle persone coinvolte, dal momento che, come accennavo in precedenza, da simili esperienze non ne dovrebbe trarre beneficio solo chi ne è il destinatario, ma anche il mittente.
Alle volte è più semplice, oltre che perversamente gratificante, fornire a chi ha fame il pesce anziché insegnargli a pescare: si risparmia tempo, ci si sente utili nel presente ma soprattutto si innesca un meccanismo di controllo, per cui se avrai di nuovo fame dovrai tornare da me, ed io ne trarrò il senso del mio operare, crederò di esserti stato utile, quando invece lo sono stato solo per me stesso. Questa è la negazione di un gesto volontario ed altruistico: impedire a chi viene aiutato di potersi aiutare da solo, grazie alla riaffermazione della propria autonomia.
Infine, forse il paradosso più subdolo e rischioso, a volte assecondato legalmente, consiste nella conversione dell’attività di volontariato in un più o meno chiaro rapporto di lavoro, in cui la variabile chiave è data dalla corrispondenza di un compenso. È paradossale che un’attività, per definizione gratuita, si trasformi in occasione di guadagno, nella migliore delle ipotesi; di subordinazione se non addirittura di sfruttamento, nella peggiore. Le tante carenze cui il mondo del volontariato e del Terzo settore supplisce a volte potrebbero e dovrebbero trovare una risposta più strutturata e strutturale se non in entrambi, quanto meno nel Primo settore, e cioè lo Stato. Che alle volte sembra strizzare l’occhiolino a forme più o meno limpide di interventi, in cui appunto i volontari sono tali solo di nome.
Il volontariato sta assumendo un forte ruolo politico perché raccoglie e traduce un’esigenza della società civile. Quasi che i cittadini si fidino più del mondo del volontariato che delle Istituzioni e della politica in senso ampio. Quasi che questo mondo rappresenti un microcosmo entro cui rifugiarsi, per sfuggire ad una società che non è più comunità, a forme più o meno strette di convivenza abitativa ed urbana che si connotano per infinite incongruenze e che ci impediscono di sentirci parte integrante di un tutto più ampio, in cui il nostro esserci, come quello di chiunque altro, non è una contingenza ma una necessità. Un rifugio in cui condividere ideali e obiettivi civici che altrove, nello spazio più ampio delle comunità civili, politiche, religiose, sentiamo non essere nostri e altrui allo stesso tempo.
Questo, da un lato, può giustamente inorgoglire chi vive e custodisce la realtà del mondo del volontariato, ma, dall’altro, dovrebbe anche destare un certo grado di preoccupazione, nella misura in cui questa tendenza viene letta come un sintomo di una disintegrazione interna alla società. Stato e volontariato non dovrebbero essere due entità in contrapposizione, come pure non dovrebbero frammistarsi al punto da non poter più essere distinte. Quelle carenze cui il volontariato supplisce sono problematiche cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione, per il semplice fatto che se ad una mia responsabilità ci pensa qualcun altro non significa che io non ne sia più responsabile. Se invece di supplire, il volontariato si integrasse nello Stato e questi gli permettesse di farlo, meno sarebbero i paradossi, e del volontariato e dello Stato.
Segui le attività della Caritas diocesana di Udine sui social
Condividi questo articolo